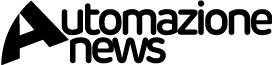Recentemente si è sviluppato su Internet un interessante dibattito i cui contenuti vogliamo condividere con i nostri lettori Il succo del discorso è questo: spesso e volentieri un dipendente è pagato troppo poco perché si senta motivato a dare un contributo extra, in sostanza per “pensare”, per contribuire al miglioramento e all’ottimizzazione dei processi nei quali è coinvolto. Il problema che si cela dietro questo assunto non è marginale, in quanto porta alla vanificazione di tutti i discorsi motivazionali su cui si basano molte iniziative aziendali. Infatti, non mancano studi, analisi e articoli di riviste specializzate su come sviluppare, motivare e anche trattenere in azienda personale qualificato, stante la crecente richiesta di competenza e specializzazione per compiti in ambito tecnico sempre meno manuali e sempre più concettuali, da un ruolo semplicemente di “homo faber” a un più evoluto ruolo di “homo cogitans”. Ma pare che tutti questi sforzi rischino di tradursi in una perdita di tempo. Stando ai risultati di serie ricerche condotte da eminente esperti della comunità accademica, saremmo di fronte al dilagare di quella che viene definita come “effort aversion”, termine con cui si vogliono concettualmente strutturare le motivazioni che portano i lavoratori a limitare il loro impegno nelle attività che l’azienda chiede loro di svolgere. Per quanto le teorie e anche le esperienze sin qui accumulate portino ad affermare che un lavoro impegnativo sia fonte di maggior interesse e soddisfazione rispetto a un’attività che richiede minori sforzi, diciamo un lavoro di routine, in realtà resterebbe un’ampia zona di insoddisfazione, conseguenza del fatto che si ritiene che i propri sforzi dovrebbero avere un’adeguata considerazione, sostanzialmente una monetizzazione. E il conflitto tra soddisfazione momentanea e insoddisfazione sul medio e lungo periodo rischia di avere effetti molto negativi, portando a una sensazione di sfruttamento. Volendo filosofeggiare, sta rafforzandosi il concetto per cui si lavora per vivere, non si vive per lavorare, nel senso che un impegno mentale eccessivo sul lavoro, posto non abbia riconoscimento, porta a una negazione del proprio privato, e di questo se ne sta perdendo il senso. Ora, se, come effettivamente è stato fatto nelle ricerche citate, si sottopongono a una persona due possibili lavori, istintivamente viene scelto quello più interessante, anche se questo richiede maggiori sforzi mentali e fisici. Ma se poi si dettagliano i valori economici, ugualmente istintivamente il focus si sposta sullo stipendio, tal per cui la scelta iniziale permane solo se è prevista una remunerazione aggiuntiva per il maggior sforzo richiesto, diversamente si propende per il lavoro più semplice. Il risultato è imbarazzante nella sua semplicità: importano più i compensi degli aspetti non monetari, anche se questo può comportare una vita meno felice o più noiosa: in pratica, essere pagati per non pensare. Veri o non veri i risultati di queste ricerche accademiche, applicabili o meno che siano per certi contesti nazionali, fasce di età o livelli di bisogno, resta un certo disagio. Ma si possono criticare questi atteggiamenti quando vi sono manager incompetenti strapagati, che anche quando portano allo sfascio un’azienda ricevono una buonuscita faraonica?