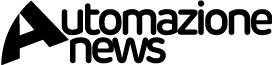Grazie all’automazione e alla meccanizzazione, la movimentazione manuale dei materiali riceve un supporto prezioso che migliora la qualità del lavoro. Ci riferiamo in particolare al ricorso agli esoscheletri da lavoro, dei dispositivi robotici indossabili che facilitano il movimento dell’utente ed evitano quei danni biomeccanici che produrrebbero un aumento dei costi per l’imprenditore e un impatto negativo sul dipendente.
Utilizzati in diversi ambiti operativi, gli esoscheletri da lavoro saranno i veri protagonisti della futura scena industriale. Contemporaneamente, però, sopraggiunge la necessità di una regolamentazione ad hoc. Alle classiche linee guida per la sicurezza e l’ergonomia sul posto di lavoro se ne dovranno aggiungere altre, in un quadro normativo ancora in fieri.
Vediamo allora nel dettaglio l’iter operativo e giuridico per l’utilizzo degli esoscheletri da lavoro, tra bisogni e requisiti necessari.
Indice dei contenuti
- Dall’idea del sostegno meccanico agli esoscheletri da lavoro
- Le tipologie di esoscheletri da lavoro: la distinzione per utilizzo e per applicazione
- Lo Human-centered design degli esoscheletri da lavoro
- L’utilizzo degli esoscheletri da lavoro: i fattori di rischio
- La normativa sugli esoscheletri da lavoro: esiste una regolamentazione?
- Lo scenario futuro: dal GL16 al mercato degli esoscheletri da lavoro
Dall’idea del sostegno meccanico agli esoscheletri da lavoro
Grazie agli esoscheletri è possibile ripristinare la funzione degli arti umani e aumentarne la potenza, con un’azione simbiotica tra l'essere umano e il robot che esegue il movimento.
Ma cosa significa esoscheletro? Il nome utilizza il prefisso exo (in greco antico, “fuori”) che indica strutture esterne (pesudo osse) nella forma di robot indossabili da diversi soggetti, lavoratori ma non solo. Sono infatti definiti protesici se utilizzati in ambito medico, e sono adoperati anche nel settore militare.
L’evoluzione di queste due tipologie ha portato a quelli che oggi indichiamo come esoscheletri da lavoro, impiegati nel comparto industriale e lavorativo. Sono utilizzati come supporto alle attività umane per la riduzione dei sovraccarichi, dalla produzione automobilistica a quella aerospaziale, dalla logistica all’edilizia.

I primi modelli di esoscheletri
Si tratta di un percorso che arriva da lontano. Nel tempo, si è creata una differenziazione specifica degli esoscheletri. Il primo modello risale al 1962 (Hardiman), in un progetto della General Electric che non ebbe però successo, probabilmente perché non accompagnato da una tecnologia matura per l’epoca. L’idea ha continuato a prendere forma, indirizzata però verso la riabilitazione umana (Berkeley Lower Extremity Exoskeleton o ReWalk Robotics).
L’esperienza italiana
È nell’ultimo decennio che gli esoscheletri da lavoro fanno ufficialmente ingresso nel comparto industriale italiano. Da Body Extender a Comau MATE, si amplia la portata di utilizzo, con un nuovo utente finale.
La tecnologia di assistenza opera sui movimenti meccanici del corpo, riducendo il carico del lavoro fisico – come nel caso del sollevamento di oggetti pesanti – e diminuendo il rischio di disturbi muscolo-scheletrici.
Le tipologie di esoscheletri da lavoro: la distinzione per utilizzo e per applicazione
Nello specifico, quindi, che cos’è un esoscheletro? Si tratta di un dispositivo capace di offrire una valida alternativa a soluzioni preesistenti, ma difficilmente praticabili. Pur rientrando nel medesimo ampio spettro, è possibile fare delle distinzioni per utilizzo e per applicazione. Esistono esoscheletri attivi e passivi. I secondi sono utili ma non contribuiscono in modo attivo all’azione, mentre gli attivi sono più partecipativi e presentano maggiori rischi. In base poi al posizionamento si distinguono in esoscheletri inferiori, superiori o completi. Vediamoli nel dettaglio
Gli esoscheletri da lavoro attivi
Partiamo da quelli attivi, che servono come supporto esterno per l’operatore, nella riduzione ad esempio di sovraccarico biomeccanico: attraverso una componente di azionamento elettrico, pneumatico e idraulico, sostengono i movimenti umani.
Grazie a un programma informatico si procede al trasferimento delle informazioni dei sensori, per il controllo dell’azione. In tal senso, l’INAIL ha sviluppato in collaborazione con IIT esoscheletri robotici indossabili che riescono a ridurre lo sforzo dei lavoratori fino al 40%. Sono applicabili in diversi comparti industriali, dal manifatturiero al logistico.
Sono di tre tipi (XoTrunk, XoShoulder e XoElbow) e forniscono sostegno rispettivamente alla schiena/tronco, alle spalle e ai gomiti.
Gli esoscheletri da lavoro passivi
Ci sono poi gli esoscheletri passivi, che facilitano le posture incongrue, supportano il movimento evitando l’affaticamento e utilizzando le forze di ripristino di molle, ammortizzatori o altri materiali.
Attraverso i gesti dell’utente si genera l’energia, immagazzinata nell’esoscheletro passivo. Si procede quindi con una ridistribuzione delle forze, a protezione delle specifiche aree del corpo.
La migliore prestazione del lavoratore non deriva, quindi, da una maggiore forza fisica meccanizzata (come nel caso degli attivi), bensì da una superiore capacità di sopportare la posizione “estenuante”. Un esempio è il prototipo presentato da INAIL che imita le prestazioni della colonna vertebrale e corregge la postura del lavoratore e mitiga il carico fisico sulla schiena.
Lo Human-centered design degli esoscheletri da lavoro
Gli esoscheletri da lavoro rappresentano dunque un’opportunità per ridurre lo stress muscolare, articolare, legamentoso e osseo sul lavoro. Assistono fisicamente i lavoratori e prevengono i DMSR. Pensiamo anche ai lavoratori con problematiche fisiche che, grazie al robot, possono svolgere compiti diversamente impossibili.
Il progetto INAIL ed EU-OSHA
In un progetto collaborativo che coinvolge l’INAIL e l’Agenzia Europea per la salute e la sicurezza di Bilbao è stato pubblicato il “Discussion Paper” sull’utilizzo degli esoscheletri da lavoro. Il documento, in particolare, si focalizza sulla questione della progettazione dei robot, con un approccio “Human-centered design”.
In un’ottica di Industria 5.0, con l’uomo al centro delle attività e la macchina quale sua estensione, la progettazione dovrà apparire simile a un abito sartoriale, studiato ad hoc per ciascun lavoratore.
L’impatto emotivo dell'uso degli esoscheletri da lavoro
In tutto ciò, l’utente non dovrà provare alcun disagio fisico ed emotivo nell’utilizzo dell’apparecchiatura. Pertanto, prima ancora di parlare degli aspetti relativi alla safety, bisognerà considerare anche la parte più “sentimentale” della vicenda, ovvero l’impatto emotivo nell’utilizzo degli esoscheletri da lavoro.
L’implementazione sarà infatti funzionale anche all’accettazione degli stessi robot. Secondo diverse pubblicazioni il dispositivo non dovrà risultare solo sicuro, comodo, utile e utilizzabile, ma anche “desiderabile”.
In altre parole, l’utente finale dovrà sentire l’esigenza e la voglia di usarlo, senza remore. È anche questo un motivo per cui potrebbe risultare intelligente scegliere, nella progettazione, un approccio incentrato sul lavoratore, coinvolgendo direttamente lo stesso nella creazione del dispositivo.
L’agilità, un altro aspetto rilevante
Gli esoscheletri attivi offrono un supporto maggiore, perché riducono maggiormente i carichi fisici rispetto a quelli passivi (alleggerendo il carico su molte articolazioni del corpo). Eppure, va anche detto che anno dopo anno (e tecnologia dopo tecnologia) il loro peso sta aumentando. Per offrire un prodotto sempre più performante si aggiungono componenti a discapito della leggerezza finale. E non è certamente un vantaggio per l’utente.
Tutto ciò va attentamente ponderato, prima di procedere con un'implementazione su larga scala. È poi necessario considerare anche le questioni di sicurezza specifiche, nel caso di esoscheletri da lavoro sia attivi che passivi, delineando differenti scenari di rischio, in considerazione di un uso prolungato.
L'utilizzo degli esoscheletri da lavoro: i fattori di rischio
Gli esoscheletri presentano una serie di vantaggi innegabili. Bisognerà porre però anche l’attenzione sui rischi connessi all’evoluzione tecnologica. Ai benefici si potrebbero infatti sommare alcune conseguenze ignote, conoscibili solo nel lungo periodo.
Effetto memoria e interferenza
Si parla, ad esempio, di “effetto memoria”, con riferimento alla muscolatura sollecitata a lungo, indossando il robot. Ma si rifletta anche sul contesto in cui si inseriscono gli esoscheletri da lavoro: per un corretto utilizzo bisognerà tener conto del luogo e della co-abitazione con altri soggetti. Diventa quindi rilevante “l’interferenza” con l’ambiente esterno: pensiamo, ad esempio, ad una possibile evacuazione, con un robot che ingombra e impedisce il passaggio attraverso spazi di dimensioni inferiori rispetto alla sovrastruttura.
Azioni volute o casuali?
Volendo anche ipotizzare una progettazione del dispositivo modellata totalmente sul lavoratore, la sostanza non cambia. Pensiamo alla soluzione degli esoscheletri antropomorfi, ovvero quelli che presentano una struttura simile al corpo umano, con una serie di articolazioni da azionare. I robot di tale tipologia seguiranno la cinematica del corpo umano e risulteranno sicuramente meno ingombranti. Replicheranno i movimenti del lavoratore, attraverso un rilevamento delle “intenzioni” fisiche. Ma quanto è sicuro tutto ciò?
Cosa accade qualora il robot non riesca a distinguere le azioni volute da quelle casuali? Si rende necessario allora un’ampia sfera di sensori e un’elaborazione del segnale che può risultare, a tratti, complessa. Non è quindi semplice procedere in tal senso o, almeno, non è veloce e immediato. E, soprattutto, va fatto secondo normative specifiche.
Rischi individuati e individuabili
Pertanto, a un interesse molto diffuso, in ambito professionale, non corrisponde ancora una paritetica implementazione su larga scala. È ancora necessaria una più ampia conoscenza degli ausiliari robotici perché, se i vantaggi sono noti a tutti, i rischi non risultano ancora totalmente individuati (e individuabili).
Come sottolinea l’INRS, l’Istituto Nazionale Francese di Ricerca e Sicurezza per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali) in una sua pubblicazione del 2019, nel lungo periodo potrebbero sorgere potenziali rischi per la salute, a causa della ridistribuzione dello stress ad altre regioni del corpo. Potrebbe essere compromessa la stabilità articolare e alterata la cinematica, con un controllo motorio destabilizzato e una maggiore e necessaria attività dei muscoli delle gambe o delle braccia. Per non parlare, poi, delle questioni tecniche, di sicurezza ed ergonomiche.
La normativa sugli esoscheletri da lavoro: esiste una regolamentazione?
Le questioni connesse all’interazione uomo-dispositivo tecnologico andranno allora affrontate ricorrendo ad una normazione specifica che dovrà considerare diversi aspetti, tra cui l’ambiente in cui si opera, le questioni organizzative e i processi. Tuttavia, al momento non esistono ancora standard di sicurezza internazionali per l’applicazione professionale degli esoscheletri e, per ovviare a questa lacuna legis, si fa riferimento a norme già operative nello scenario giuridico, attraverso le quali è possibile reperire informazioni utili, grazie a concetti applicabili a diversi attori e campi.
Norme di carattere generale
Tra le norme di carattere generale menzioniamo la UNI EN ISO 26800:2011 (https://store.uni.com/uni-en-iso-26800-2011), che descrive l’approccio generale all’ergonomia e specifica i principi e i concetti fondamentali applicabili, la UNI EN ISO 10218-1:2012 e la ISO/TS 15066:2016 (ISO/TS, 2016), entrambe focalizzate sui requisiti di sicurezza per i robot industriali e i robot collaborativi.
Norme di ergonomia
Per le norme di ergonomia per la progettazione e gestione di sistemi e attrezzature è consultabile la UNI EN ISO 27500:2017 che offre spunti per gestire un’organizzazione orientata sull’uomo, riportando anche i vantaggi economici derivanti da tale impostazione, così come i rischi.
Nel medesimo ambito troviamo la norma UNI EN ISO 9241-220:2019, che descrive però i processi e i risultati di una progettazione che soddisfi requisiti di qualità orientati all’utente finale, e la ISO 9241-210:2019 (EN ISO, 2019), relativamente all’ergonomia e ai fattori umani nell’organizzazione efficace dello Human-centered Design (HCD).
Per una progettazione incentrata sull’uomo c’è la ISO 9241-210:2010, con un approccio che migliora l’efficacia, l’efficienza e la soddisfazione dell’utente, così come l’accessibilità e la sostenibilità, contrastando i possibili effetti negativi sulla salute, la sicurezza e le prestazioni umane.
Norme di accessibilità ed esoscheletri “macchina”
Le norme dedicate all’accessibilità sono invece la UNI EN ISO 9241-971:2022 “Ergonomia dell’interazione uomo-sistema - Parte 971: Accessibilità dei sistemi interattivi tattili/aptici” e la CEN ISO/TR 22411:2021 “Ergonomics data for use in the application of ISO/IEC Guide 71:2014”. Possiamo poi identificare le norme dedicate allo spazio e al carico di lavoro: la UNI EN ISO 6385:2017 “Principi ergonomici nella progettazione dei sistemi di lavoro” e la UNI EN ISO 10075 (parti da 1 a 3), “Principi ergonomici relativi al carico di lavoro mentale”.
Qualora, invece, gli esoscheletri da lavoro vengano immessi sul mercato comunitario europeo come macchina, andranno considerate le norme tecniche per la sicurezza del macchinario. Tra queste sono incluse UNI EN 614-1:2009, UNI EN 614-2:2009, UNI EN 1005-1:2009, UNI EN 1005-2:2009, UNI EN 1005-3:2009, UNI EN 1005-4:2009, UNI EN 1005-5:2007 e UNI EN ISO 14738:2009. Infine, una norma che si avvicina particolarmente alla materia è la ISO/DIS 18646-4, sulle prestazioni dei robot di supporto lombare.
Lo scenario futuro: dal GL16 al mercato degli esoscheletri da lavoro
La casistica delle norme simili tuttavia non basta. È per questo che il 1° aprile 2020 la Commissione Centrale Tecnica dell’UNI ha approvato la creazione di un nuovo Gruppo di lavoro nella commissione UNI/CT 042. Si tratta del GL16 in materia di “Sicurezza e salute dei dispositivi indossabili per agevolare le attività lavorative”.
Il Gruppo di Lavoro 16 e il Technical Report
Denominato ufficialmente UNI/CT 042/SC 01/GL 16, l’organo tecnico si occuperà di delineare la normazione relativa ai dispositivi indossabili. In questa categoria sono inclusi sia esoscheletri (attivi e passivi) sia schermi, caschi e altri dispositivi finalizzati ad agevolare le attività lavorative. In tale ambito è stato redatto un rapporto tecnico, UNI1611109 “Sicurezza e salute nell’uso degli esoscheletri da lavoro orientati ad agevolare le attività lavorative”, che ha per oggetto i dispositivi indossabili e portatili di servizio.
Il Technical Report, che “fotografa” l’attuale scenario, è stato sottoposto a inchiesta pubblica e lo scorso 4 febbraio 2024 è scaduto il termine per presentare commenti a riguardo. Al momento si trova quindi nella fase successiva, procedendo con il percorso di regolamentazione. Nel mentre dobbiamo allora constatare che, sebbene gli esoscheletri da lavoro vengano commercializzati, restano ancora un prodotto in fase di sviluppo.
Manca una letteratura scientifica definitiva sugli effetti positivi o negativi a lungo termine. Viene quindi applicato ancora il principio precauzionale. Gli studi epidemiologici in fieri dovranno dimostrare un’efficacia su larga scale, ma non è semplice, e non esistono metodi valutativi alternativi. Sarà quindi necessario sviluppare nuove metodologie, con una prospettiva olistica che connetta uomo, ambiente di lavoro e dispositivo indossabile.
DPI o non DPI?
Ricordiamo, poi, che gli esoscheletri da lavoro non possono ancora essere considerati DPI (Dispositivo di Protezione Individuale), ai sensi dell’articolo 74 del D.Lgs 81/2008, proprio come chiarisce il comma 2 dell’articolo de quo. Se il dispositivo di protezione individuale è un'attrezzatura indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo “contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro”, qualora “l’indumento di lavoro” non sia specificamente destinato a tale scopo uscirà dal perimetro definitorio di DPI. Non dimentichiamo inoltre la marcatura CE, ricevuta solo dagli esoscheletri (e non tutti) riabilitativi, classificati come presidi medici.
Mercato e previsioni di crescita
È quindi necessario dare ai robot indossabili una reale collocazione normativa ben strutturata, anche in funzione dell’aspetto economico. Consideriamo che, oggi, il costo di un esoscheletro varia dai 4mila ai 6mila euro, con una dimensione globale del mercato che cresce di anno in anno. Nel 2022 il valore di questo mercato è stato stimato in 568 milioni di dollari, che sono diventati 700 nel 2023, con una previsione pari a 9,3 miliardi entro il 2030, e un CAGR del 42%. A questi dati, poi, vanno aggiunti quelli dell’indotto, che ne trarrà beneficio in ugual misura.
Pertanto, torneremo presto a sentir parlare di esoscheletri da lavoro, perché rappresentano indubbiamente il futuro economico dei produttori, e quello operativo delle aziende utilizzatrici.